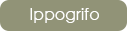Ariosto e Tasso, i luoghi letterari
Ariosto e Tasso, i luoghi letterari
in “Cartapesta”, n. 10, marzo-maggio 2004, Imola
Uno era irrequieto, ipersensibile, malato di “umor malinconico”.
L’altro era misurato, ironico e brontolone, probabilmente piuttosto furbo.
Uno condusse un’esistenza instabile, sofferta, quasi avventurosa, caratterizzata da scatti impulsivi, crisi repentine, angosciose evasioni, dolorosi pentimenti.
L’altro ci consegna l’immagine di un uomo pacifico, disincantato osservatore dei costumi di corte, conoscitore del mondo, saldamente ancorato al sereno orizzonte dei propri affetti familiari e ai giochi diplomatici della vita di corte.
Furono due poeti, egualmente grandi, allo stesso modo sfuggenti, eppure profondamente diversi: Ludovico Ariosto e Torquato Tasso.
La città di adozione era la stessa: Ferrara. Ma due esperienze così distanti, benché consumatesi a distanza appena di una generazione, sarebbe difficile rinvenirle nella storia della letteratura.
Ariosto, dopo la morte del padre, fu costretto nel 1500, nel sofisticato (e solo in apparenza sedentario) clima intellettuale della corte estense, a dover crescere la famiglia, a cercarsi un minimo di stabilità lavorativa, a guadagnarsi la vita e mantenere i suoi cari, quindi si avvicinò a Ferrara con un atteggiamento disincantato, senza particolari illusioni, con uno spirito equilibrato e pacato.
Tasso veniva da lontano, come un “forestiero”, dopo inquieti vagabondaggi (Sorrento, Salerno, Napoli, Roma, Urbino, Venezia, Padova, Bologna, Mantova), prima per seguire la sorte tormentata del padre, poi alla ricerca di una personale stabilità, per entrare finalmente al servizio del cardinale Luigi d’Este nel 1565, desideroso di gloria, carico di aspettative e sogni, idealista, animato da un’ambizione un po’ morbosa.
Basterebbero queste premesse a dare la cifra di due sensibilità contrapposte.
Se non fosse che a complicare le cose, è ovvio, ci si mette anche la storia.
È fuori di dubbio infatti che fra l’equilibrio controllato di un Ariosto e l’inquieta malinconia del Tasso ci sia di mezzo qualcosa come il tramonto del Rinascimento, la crisi della leadership ferrarese (e forse anche europea) rispetto alle nuove rotte oceaniche, l’ombra della Controriforma e del Tribunale dell’Inquisizione, un matrimonio scomodo come quello fra Ercole II d’Este e la protestante Renata di Francia, la sopravvenuta crisi economica: insomma il declino di quello slancio energico e intraprendente che fino a qualche decennio prima aveva animato gli intellettuali italiani che gravitavano attorno alla corte estense.
E non è un caso, per dire tutta la verità, che nella stessa opera di Ariosto, così limpida e solare, dominata dalla forza inesauribile della fantasia, si insinui un colore fosco, un presentimento di oscurità, nei tardivi Cinque canti che si collocano proprio all’inizio della parabola discendente del Rinascimento.
Nessuno stupore, allora, se la storia della poesia tassiana, così come la storia del suo stesso autore, è accompagnata dagli aggettivi del travaglio, dell’inquietudine, della insicurezza.
Tant’è vero che se scendiamo nel dettaglio delle opere la discrepanza fra i due si accentua e meglio si delinea.
Il genere, a un occhio disattento, potrebbe sembrare il medesimo: il poema.
Ma per essere precisi basterebbe caratterizzare il poema di Ariosto con l’attributo di “cavalleresco” e quello del Tasso con l’attributo di “epico”, e già i conti sarebbero fatti, perché nel caso dell’Orlando furioso ci imbattiamo in una struttura dinamica, aperta, estrosa, permeata di rapidità, capace di sprigionare infinite storie colorate, immaginarie, fatate, mentre la Gerusalemme liberata si costruisce su un impianto faticosamente unitario, in una difficile conciliazione fra momenti eroici e momenti lirici, in una irresolubile compresenza di luce e ombra, storia e fantasia, ragione e sentimento.
È noto che un’opera letteraria, quando è universale e parla oltre le frontiere dei secoli, possiede la rara magia di toccare il cuore dell’uomo.
In forme diverse il Furioso e la Liberata hanno centrato questo bersaglio: il primo muove le corde della creatività, dell’invenzione, della libertà, dell’evasione, del sogno; la seconda stimola la commozione, la malinconia, frammenti d’amore e di morte.
Ognuno di noi saprà riconoscere qualcosa di sé in quei libri e in quei poeti: due vite parallele e due sensibilità che in qualche modo diventano l’emblema di un secolo in crisi e, più in generale, di una condizione umana.