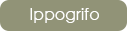Copertina
L’alba del giorno seguente
https://www.amazon.it/Lalba-giorno-seguente-Andrea-Pagani/dp/8888775110
Postazione
(Capolinea)
di Antonio Castronuovo
La vicenda
Sette storie. Sette esperienze di vita quotidiana. Sette uomini e donne, gente comune, spesso personaggi sbiaditi, incolori, fissati nelle minute occasioni della cronaca. Poi, ad un tratto, capita un evento imprevisto. Un episodio, apparentemente banale (un odore, una musica, un incontro in un anonimo autogrill, un sogno…), e la vita di quel personaggio subisce una violenta scossa tellurica, viene attraversata da un trauma profondo, riemergono ricordi sepolti, si dischiude una verità. E soprattutto quella inaspettata rivelazione apre scenari nuovi nel futuro: l’alba del giorno seguente avrà colori e significati inediti. I sette episodi di questo libro sono tessere autonome di mosaico generale: ogni episodio si può leggere a se stante, è un frammento dotato di senso, è l’inizio e la fine del libro. Ma, allo stesso tempo, sono sette episodi legati fra loro, s’intrecciano in un disegno organico, sono uno la continuazione, il completamento e l’approfondimento dell’altro. E la fine? In una spirale del genere, forse, la fine non esiste, o meglio è il lettore, che diventa una specie di nuovo investigatore, che deve trovare il finale, che è direttamente investito del ruolo del narratore.
Primo episodio
L’alba del giorno seguente
Viveva un tempo, isolato nelle praterie dell’Alentejo, disperso in mezzo all’oro dei campi di grano e all’argento degli uliveti, un uomo di nome José, uomo retto e timorato di Dio. Egli abitava con la sua famiglia (la moglie Sofia e i figli Javier e Joaquim) in un casolare bianco di calce, in quella terra gialla increspata a tratti dalle colline e popolata dalle giganti querce di sughero.
José era un uomo generoso e conduceva un’esistenza modesta: piccolo agricoltore alle dipendenze del potente latifondista Diogo Pires, facoltoso proprietario della Serra de Ossa, José s’era amalgamato ormai coi ritmi stagionali del lavoro dei campi – vendemmiare, battere il grano, arare, sfogliare la corteccia degli alberi, torchiare – e non chiedeva niente di meglio che continuare a vivere così, nel casolare bianco di calce, confortato dal calore della sua famiglia.
Tuttavia il destino non gli fu propizio.
Un giorno Rafael de Borba, uomo litigioso e prepotente, ricco proprietario delle terre di Monsaraz, che si estendevano fino alle sponde del Lago de Conde Ferreira, decise di vendicarsi di un antico oltraggio di Diogo Pires. Per la verità, non si conoscevano i termini esatti del dissidio che, da secoli, lacerava le due nobili famiglie: era una feroce discordia che si perdeva nella notte dei tempi e che, dagli antenati, si tramandava di generazione in generazione. Ma tant’è che accadde: un limpido giorno di primavera, quando il paesaggio lievemente ondulato della prateria era acceso di un vigoroso giallo ocra, il silenzio del meriggio fu rotto dalle urla dei soldati a cavallo di Rafael de Borba. Fu un agguato vile e spietato. Gli uomini di Rafael assalirono le povere abitazioni d’argilla dei contadini di Pires, distrussero i raccolti, uccisero donne e bambini. Quel pomeriggio, d’inaspettata violenza, José tagliava, sotto il sole ostinato della Serra, i tronchi delle querce di sughero e si salvò dal feroce agguato dei Borba. Ma avrebbe preferito altrimenti, giacché sua moglie e i suoi figli vennero trafitti dalle sanguinarie armi nemiche.
A quel punto si aprì nel cuore di José un dolore sterminato. Egli non si dava pace d’essere sopravvissuto a quella tragedia, d’aver lasciato sola e incustodita la sua famiglia e si sentiva responsabile di quanto era accaduto. In ogni momento della giornata rivedeva il volto dolce e malinconico della moglie. Ogni notte era visitato nel sonno dalle tenere immagini dei due figli. E non lo consolavano certo le notizie della feroce vendetta che il suo padrone aveva ordito, le notizie della strage che gli eserciti di Diogo Pires avevano consumato nelle terre di Monsaraz. La guerra macerava quelle giornate, ma egli era avviluppato nel suo disperato solitario tormento.
Eppure la vita di José era destinata ad essere scossa di nuovo.
Durante uno dei consueti incubi notturni, José fu visitato dalla voce del figlio Joaquim: era solo un filo di voce, sordo e strozzato, ma non c’era dubbio, era lui, il figlio maggiore. Quella voce sottile lo invitava a reagire, a provare pietà per le future vittime della guerra e gli suggeriva di scavare fra le radici di un enorme leccio, alle pendici della Serra de Ossa, vicino alla piccola borgata di Redondo.
La mattina seguente José, alle prime luci dell’alba, sellò il suo cavallo migliore e s’avviò lungo la strada serpentina e dissestata che univa il suo casolare di calce al paese di Redondo. Sapeva bene qual era il leccio gigante di cui gli aveva parlato Joaquim. Infatti lo trovò lì, solenne, sfiorato dai bagliori lattiginosi dell’alba, perfettamente piantato per terra. Allora José cominciò a scavare, prima con la vecchia vanga che usava nei campi, poi con le mani, con le unghie, nella terra secca e bruna, caparbia ed ostile, di cui egli conosceva bene la natura e che non lo metteva certo in soggezione. Sembrava ci fosse qualcosa di inquieto in quell’uomo tarchiato e muscoloso che azzannava le zolle di terra con un ringhio affannoso, fino a farsi sanguinare le dita, nell’aria spettrale e vagamente nebbiosa della mattina. I ciottoli, scalzati dal terriccio, giacevano in selvaggio disordine fra l’erba tenace che saliva fino alle caviglie. Il cinguettio degli uccelli pareva impaurito. L’operazione continuò per almeno due ore. Ma alla fine José rinvenne ciò che cercava. Erano polverose ossa di animale. All’inizio anch’egli non si capacitava del senso di quella scoperta, poi lentamente riaffiorò la memoria di una leggenda antica, una leggenda che suo nonno gli raccontava e che, a sua volta, il nonno del nonno aveva tramandato fino a lui. Era la leggenda di due uomini che, su quel sentiero presso Redondo, avevano aperto una feroce contesa per la proprietà di un mulo e che, per un così futile motivo, avevano scannato le loro famiglie.
Quei due uomini erano i progenitori di Diogo Pires e di Rafael de Borba.
Fu allora che José comprese il significato del suo sogno. Il figlio l’aveva instradato verso la verità: la guerra efferata che da secoli lacerava le due nobili casate era ancora più insensata, poiché nasceva dal possesso di uno stupido mulo! Non c’era stato alcun reale oltraggio fra le due famiglie.
José montò subito sul suo cavallo, galoppò come una furia fino alla sontuosa quinta del suo padrone, fu accolto nel salone degli ospiti, invocò rapida udienza, espose al suo signore non senza affanno ciò ch’era accaduto nelle ultime ore, lo pregò di por fine a quell’inutile massacro.
Con sgomento e stupore, José scorse una fiamma bruciare negli occhi di Diogo Pires, vide aggirarsi sul suo volto un diabolico sorriso d’ironia e di rabbia, e infine sentì il tono rude della sua voce che lo minacciava, che gli intimava d’andarsene subito, che gli imponeva di non raccontare quella storia a nessuno, altrimenti sarebbe stato privato di tutti i suoi beni e sarebbe stato cacciato dal latifondo. José era sconvolto da quelle parole, ma non rassegnato. Si fece coraggio, uscì dal palazzo e cavalcò, fra mille pericoli, verso la proprietà di Rafael de Borba. Anche a lui cercò di spiegare che non esisteva alcuna ragione di offesa fra le due nobili stirpi, ma non ottenne niente di meglio, anzi fu minacciato di morte.
A questo punto la storia di José si fa confusa. Alcuni raccontano ch’egli fu attraversato dalla follia e che uccise i due potenti signori assicurandosi così morte sicura. Altri dicono ch’egli tornò al suo casolare e visse in solitudine gli ultimi suoi giorni. Altri ancora asseriscono – e pare essere questa l’ipotesi più probabile – ch’egli abbandonò la sua proprietà e peregrinò, sconsolato e dolente, sulle alture della Serra de Ossa, con la compagnia solo del suo migliore cavallo, che sferzava spesso e con accanita violenza, per ricordargli che a volte la vita può essere inspiegabilmente ingiusta.
Capolinea di Antonio Castronuovo
Ogni personale letteratura è fatta di pezzi schiodati: essendo pezzi, se ne scrive uno oggi, uno tra una settimana, e così via. Scrivere a pezzi è la fisiologia della letteratura, soprattutto dopo la deflagrazione del Novecento, che ha spezzato lo spezzabile, diviso il divisibile. E la scrittura era tra queste cose, forse perché materia tenuta fragilmente insieme da uno sforzo di sintesi che poi, a un certo punto, è sembrato vano: ed ecco l’annotazione di viaggio, ecco la rinascita del racconto (genere giudicato di scarso seguito), ecco i carteggi, giù giù, fino all’aforisma e al frammento. Ma il bello viene dopo, quando si decide di radunare articoli e racconti, per togliere loro quella cera da profughi che hanno quando sparsi su giornali e riviste. Così ha fatto Andrea Pagani, che ha pubblicato racconti su riviste (e in parte li ha tenuti nel cassetto) e ha atteso il giorno in cui la decisione di metterli assieme è giunta a maturazione. Perché se le grandi forme letterarie hanno conosciuto il destino della frammentazione, viceversa è destino dei pezzi nascere sparpagliati e mirare infine a una tollerabile unione. E qui emerge qualcosa d’inatteso: che dall’accostamento dei pezzi sbuca fuori, per dirla in maniera altisonante, una “filosofia di vita”. Perché se da un racconto isolato emergono alcuni significati, dall’unione di molti racconti si può rilevare quanto quei significati siano ricorrenti. A leggere L’alba del giorno seguente si può ad esempio fiutare come solo nella luce aurorale alberghino le rivelazioni, e accorgersi quale forza possano avere un oggetto o un rumore nel risvegliare oscure situazioni del passato o palesare un’identità. Ma altre cose si intuiscono in questi racconti: quanto imperscrutabile sia il destino che circoscrive le azioni dell’uomo, a cui non resta che adeguarsi al flusso della sorte e accoglierne i benevoli fantasmi. Ancora: si scorge come un fatto, sepolto nel profondo, riemerga e si riveli radice del dolore, come fa l’indomabile colpa oscura, che vischiosa ti scorre al fianco e mai t’abbandona. Si contempla come il senso della vita dimori stabilmente nei valori, ideali, significati. Questo è ciò si fiuta in questi racconti, e compito di chi redige una postfazione (mesta voce chiamata a sollevare un grido nel solitario piazzale del capolinea, quando tutti sono già scesi) è almeno di indurre al sospetto che qualcosa ci sia più delle parole. Il narratore, infatti, ha ben dissimulato i significati nella pura manifestazione di uno stile sapientemente terso e studiato. È sempre così: mentre leggi, il senso si accuccia nelle parole, e forse addirittura parole e senso sono la stessa cosa. Ecco perché se vuoi leggere cose buone è meglio commerciare con chi narra in modo neutro ma pieno d’anima, come sa fare l’autore di queste pagine. Invereconde parole, nude per chi le analizza e per chi le ruba da “lettore semplice”: nude ma cariche di senso. Figure leggere e affardellate a un tempo, ombre che attraversano la pagina e incardinano la fisiologia narrativa di Pagani. Scrittore che ti seduce con la miscela di destini, colpe e segreti. E te ne contagia.
Lasciate i vostri commenti cliccando qui contatti