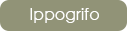Un poeta puro
Un poeta puro
in “sabato sera”, Imola, novembre 2003
Ogni poeta, si sa, ha un prima e un dopo. Ogni poeta ha una tradizione che lo ha preceduto e una schiera di posteri che lo attende. Ogni poeta, quindi, deve fare i conti con una serie di consuetudini letterarie e anche di regole che sono alle sue spalle (il cosiddetto canone) e cerca di misurare la sua originalità alla luce di quel canone.
Ecco perché è difficile capire quanto un poeta sia innovativo per gli uomini che l’hanno conosciuto: sono in pochi a saper valutare la portata e la forza rivoluzionaria di un’opera d’arte, al di là delle esperienze biografiche dell’autore; sono in pochi a saper travalicare le minute occasioni della cronaca e disancorarsi da una tradizione che incombe.
Ebbene, c’è un poeta che ci interessa molto da vicino, poiché alcuni momenti della sua vita attraversano la città di Imola; un poeta su cui ha troppo a lungo pesato il giudizio dei contemporanei e che possedeva invece un’inusuale energia artistica, un’energia che – solo oggi ce ne rendiamo conto – era destinata ad aprire le porte del Novecento letterario. Un poeta, la cui tormentata vicenda umana è, per molti aspetti, ancora avvolta nel mito. Quel poeta risponde al nome di Dino Campana.
E il fatto più curioso – come ricorda il bellissimo romanzo biografico di Sebastiano Vassalli, La notte della cometa – è che fu proprio Campana a spiegare il valore della sua poesia (quanto furono ciechi e ottusi i suoi contemporanei a non saper cogliere quel suggerimento!), quando in epigrafe al manoscritto dei suoi Canti Orfici, in possesso di Ardengo Soffici e dimenticato in un armadio per più di sessant’anni, aveva spiegato che “essere un grande artista non significa nulla: essere un puro artista ecco ciò che importa”.
Cosa intendeva Campana con questa frase? Qual è la differenza fra “grande” e “puro” artista?
Una cosa molto semplice, e al tempo stesso profonda: il grande poeta, secondo Campana, è un autore che vive in pieno nel suo tempo, nel presente, celebrato nell’epoca in cui vive, ma che lì finisce, senza gettare ponti coi posteri, senza dialogare con l’eternità. Il poeta puro, invece, è fuori dal tempo e sa cogliere la sostanza universale delle cose, col rischio tuttavia di rimanere isolato ed incompreso.
Fu questo il destino del “pazzo” di Marradi.
E non è un caso ch’egli abbia posto ad epigrafe del suo libro questa serie di riflessioni, perché qui c’è esattamente tutto il suo dramma, forse il tema dominante della sua vita, e cioè il contrasto radicale fra l’uomo e la cultura dell’epoca, fra le esperienze biografiche e il giudizio dei contemporanei, fra il valore delle sue poesie e il marchio della follia che vollero imprimergli. Una riflessione sulla vita e sull’opera di Dino Campana, infatti – per quanto breve e sommaria possa essere -, non può disconoscere un aspetto così determinante come la pressione (verrebbe da dire, la violenza) che la società del tempo esercitò su di lui, a partire dal contesto familiare, fino ad arrivare ai sistemi manicomiali dell’epoca. Ed ecco perché il “caso” Campana, in ultima analisi, ci permette anche di esaminare le contraddizioni e gli orrori di certe strutture psichiatriche del primo Novecento.
Il ricovero a Imola
In tutto questo, dicevamo, la città di Imola non è affatto estranea, anzi per certi aspetti è una diretta protagonista. E in almeno tre circostanze. Prendiamo in esame, allora, le tre – come dire- “esperienze imolesi” di Campana, che magari ci potranno dare qualche spunto sulla poetica dell’autore, così singolarmente visionaria ed evocativa.
La prima esperienza, quella più nota.
Per la verità la famiglia Campana aveva già avuto a che fare con Imola, quando Dino era ancora un bambino: il padre, Giovanni Campana, maestro elementare, comincia ad accusare fra il 1890 e il 1895 “disturbi nevrastenici” e, dopo aver provato a curarsi da solo con le tisane e gli infusi del farmacista di Marradi, una domenica mattina di un anno imprecisato, fra 1895 e il 1900, si presenta spontaneamente al manicomio di Imola e chiede ad un certo dottor Angelo Brugia di curarlo dal suo male. Si tratta di un antefatto importante, poiché quando sei anni dopo si verificò un altro imbarazzante caso analogo in casa Campana, il primo pensiero andò a quel medico di Imola ch’era riuscito a guarire il maestro Giovanni con un paio di “polveri miracolose”.
Tocca cioè al giovane Dino. Egli – secondo la testimonianza del padre – fra il 1900 e il 1905 “dà prova di un’impulsività brutale, morbosa in famiglia e specialmente colla mamma”. Il libro di Vassalli, che è insieme una rigorosa ricostruzione biografica e un suggestivo romanzo, è stato capace di restituirci l’atmosfera repressiva e cupa che si respirava in casa Campana in quegli anni, con l’ombra di uno zio “pazzo” (ricoverato in manicomio nel 1904, dov’era morto nel 1909), con i disturbi e i disagi del padre e, soprattutto, con le violente pressioni psicologiche della famiglia affinché Dino studiasse chimica (figurarsi com’erano viste le fantasie poetiche e la vita errabonda del ragazzo…).
Sulle “stranezze” di Dino aleggia ben presto l’ombra del sospetto. Vagabondaggi, poesie, atti di rivolta verso chi vuol fargli studiar chimica. Nasce da qui il mito della follia. Così, dopo una visita psichiatrica dal professor Giovanni Vitali di Bologna, da cui il maestro si fa scrivere una lettera necessaria per l’internamento del figlio, il 4 settembre 1906 Dino Campana approda ad Imola e varca il portone del nosocomio psichiatrico “Lolli”, affidato alle cure del dottor Brugia (purtroppo è andata perduta la cartella clinica).
Fu un’esperienza atroce. In quell’ospedale egli non vi rimase nemmeno due mesi (fino al 31 ottobre 1906), ma i segni di quel soggiorno rimasero impressi per sempre nella sua mente.
“Essendo una persona normale – scrive Vassalli -, Dino reagisce al manicomio alternando crisi di sconforto e accessi di furore: si ribella e viene battuto, urla e lo legano al letto, insomma si comporta da pazzo”, cosicché il giovane di Marradi, se era entrato nel manicomio di Imola con qualche “stranezza” o bizzarra velleità poetica, vi esce che ormai è “pazzo accertato”, con sentenza di Tribunale, “non più padrone di sé ma costretto a farsi rappresentare da un tutore”.
Tre settimane e mezzo di passione
La seconda esperienza imolese di Campana è di dieci anni posteriore.
Anche in questo caso, la vicenda biografica si colora di leggenda e di avventura: stiamo parlando, infatti, di una fra le più brucianti storie d’amore del Novecento letterario, la passione fra Dino Campana e Sibilla Aleramo.
La città di Imola viene trasversalmente toccata da questa celebre vicenda sentimentale, come ci rivela un articolo di Antonio Castronuovo, dal titolo assai emblematico, che richiama una nota pellicola cinematografica: “Tre settimane e mezzo. Dino Campana sulla Montanara”.
Castronuovo osserva che il periodo più intenso della relazione amorosa fra i due, durata appunto tre settimane e mezzo, “si svolse tutt’intera lungo la via Montanara, quella che congiunge Imola e Firenze, tra le località di Rifredi, Barco, Casetta di Tiaria”, cosicché l’attenzione dello studioso arriva a dimostrare una duplice svista: di Sebastiano Vassalli che confonde Casetta di Tiara con la località di Casetta, “che, subito sotto il Passo della Raticosa e prima di Covigliaio, si trova rispetto a Firenzuola dalla parte esattamente opposta all’antico e romantico borgo che domina dall’alto la valle del Rio Rovigo, esiguo affluente del Santerno”; e la svista della stessa Aleramo, che in una testimonianza del 1950 oltre ad indicare in Rifredi la città nativa di Campana, anziché Marradi, ricorda anche che il “delirio selvaggio” della passione divampò a Casetta di Chiara, anziché Casetta di Tiaria.
Tuttavia, ciò che colpisce di questa focosa avventura amorosa è, ancora una volta, un aspetto umano e letterario insieme: da un lato, l’immagine di una donna quarantenne, consumata seduttrice, dai modi vagamente dannunziani, “campionessa di emancipazione femminile”, ora ricondotta ad una passione libera e umanissima, che la rende quasi vulnerabile; dall’altro lato il nostro Dino, che nonostante i due ricoveri manicomiali e l’etichetta ormai consolidata di “pazzo”, si mostra “tranquillo, dolcissimo innamorato come un bimbo”.
Dunque, una bruciante e romantica storia d’amore, nella cornice suggestiva delle nostre colline, fra le valli dove s’incontrano il Santerno, il Rovigo, il Veccione.
Una cartolina dispersa
Passiamo così alla terza traccia imolese nella vita di Campana, relativa ad un recentissimo rinvenimento bibliotecario.
Agosto 1917. Campana attraversa una stagione drammatica, forse la peggiore della sua vita. La relazione con l’Aleramo s’è ormai consumata dopo aver assunto tratti spesso tormentati e violenti; i segni di squilibrio sono più frequenti; il poeta è alle soglie dell’internamento (gennaio 1918) al manicomio di Castel Pulci dove morirà nel 1932.
Ebbene, in quella stagione dolorosa della sua vita, Campana scrive una cartolina con vista di Marradi, al poeta e librettista d’opera Luigi Orsini di Imola, morto nel 1954. Questa cartolina, fino ad ora incredibilmente passata inosservata, è stata rinvenuta qualche mese fa da Antonio Castronuovo, nella cartella numero 4 dell’Archivio Luigi Orsini, conservato presso la Biblioteca Comunale di Imola. Per chi volesse fare un sopralluogo nella nostra biblioteca cittadina potrà facilmente accedere a questo ricchissimo fondo, composto da 70 voluminose buste di epistolari, rigorosamente ordinate per mittente, fra i cui nomi troviamo non pochi personaggi illustri (D’Annunzio, Puccini, Alfano, Casella, Moretti, Spallicci, Codronchi detta Sfinge). E combinazione vuole che ci sia anche una cartolina di Dino Campana, che reca il timbro postale del 19 agosto 1917.
Ma come si conobbero i due? Quale contesto storico o situazione personale permise l’incontro fra il “pazzo” di Marradi e lo scrittore di Imola?
Castronuovo ricostruisce la dinamica di quella breve ma bizzarra conoscenza grazie ad un libro autobiografico dello stesso Orsini, “Il mio sentiero”, in cui un capitolo è interamente dedicato allo “strano incontro” (così lo definisce lo stesso Orsini) fra i due autori. Orsini narra che nell’estate del 1917, insieme ad un amico musicista faentino che insegnava a Genova, Giuseppe Cicognani, aveva organizzato una gita podistica da Faenza a Badia Prataglia: “Giunti a un certo punto elevato della via provinciale – racconta Orsini – che congiunge, se ben ricordo, la Romagna col Casentino, entrammo in un’osteria a rifocillarci. Mentre stiamo mangiando, si presenta, e viene a sedersi vicino a noi, senza che nessuno lo abbia invitato, un giovane dall’aspetto strano. Ha un volto delicatissimo, incorniciato da una barba bionda che gli dà quasi l’aspetto di un asceta: e dell’asceta ha anche gli occhi chiari, ora lampeggianti, ora assorti”.
Così la comitiva dei tre decise di proseguire insieme verso il Castagno, chiesetta ai piedi della Falterona, dove fu accolta dal curato che li ospitò per la notte. Dopo una breve dormita, mentr’era ancora buio, i tre ripartirono verso Falterona per contemplare lo spettacolo dell’aurora. Sarà nella tarda mattinata di quel giorno – che Castronuovo ipotizza essere fra il 17 e il 18 agosto 1917 – che si verificò l’episodio bizzarro ricordato da Orsini: improvvisamente Campana, intravisti due carabinieri, saltò giù per un prato e scomparve, essendo già stato più volte arrestato nella sua vita.
Preso dall’euforia di quell’incontro, Campana nelle ore successive invia la cartolina a Luigi Orsini, un documento che non riveste un particolare valore storico e letterario, se non fosse per un inciso che il poeta scrive fra parentesi: “Rispettosi saluti devmo Dino Campana (soffre). Marradi”.
È significativo che in una missiva frettolosa, ad una persona che conosceva appena, Campana voglia aggiungere quella parola, “soffre”, sotto il proprio nome, quasi a sottolineare lo stato emotivo che lo dominava in quei mesi dolorosi.
E torniamo così alle ragioni di quell’anima disperata. Certo non è possibile – e forse neppure lecito – comprendere con precisione le radici di una malattia della mente. A distanza di tanti anni, e specie senza la possibilità di parlare con testimoni diretti e con lo stesso protagonista, ogni ipotesi sulla “pazzia” del poeta di Marradi riesce davvero coraggiosa e ingiusta.
Ma una domanda, ci pare, abbiamo il diritto e magari il dovere di porla: cosa poteva aver significato per un giovane semplicemente un po’ stravagante, con qualche grillo poetico mal tollerato dai genitori, magari un po’ lunatico, venire a contatto coi manicomi di un secolo fa, ovvero – come rilevano molti resoconti – con poveri cristi che fanno i bisogni ovunque, mangiano scarafaggi e vermi, tentano continuamente d’accoppiarsi o si masturbano, alternano stati di ebetismo a scatti di nervosismo e aggressività, poveri cristi a cui l’ambiente ha fatto perdere ogni dignità, ogni barlume di una superstite lucidità che forse avevano prima d’entrarvi? Non può sorgere il dubbio che quella stravaganza d’artista – che magari oggi viene salutata come sinonimo di genialità – sia degenerata in follia, o meglio in disperazione, dentro le mura di una simile prigione?
Andrea Pagani
BIBLIOGRAFIA
Sibilla Aleramo-Dino Campana, “Un viaggio chiamato amore. Lettere 1916-1918”, Feltrinelli, Milano, 2002
Dino Campana, “Le mie lettere sono fatte per essere bruciate”, Scheiwiller, Milano, 1978, a cura di Gabriel Cacho Millet
Antonio Castronuovo, “Tre settimane e mezzo. Dino Campana sulla Montanara”, in “Università Aperta – Terza Pagina”, ottobre 2000, n. 9
Antonio Castronuovo, “Dino Campana e Luigi Orsini: storia di un incontro”, in “Università Aperta – Terza Pagina”, dicembre 2001 n. 11.
Luigi Orsini, “Il mio sentiero”, Gastaldi, Milano, 1951
Carlo Pariani, “Vite non romanzate di Dino Campana scrittore e Evaristo Boncinelli scultore”, Vallecchi, Firenze, 1938
Sebastiano Vassalli, “La notte della cometa”, Einaudi, Torino, 1984
Sergio Zavoli, “I giorni della meraviglia. Campana, Oriani, Panzini, Serra e i giullari della poesia”, Marsilio, Venezia, 1994