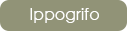C’è una pagina del Decameron di Giovanni Boccaccio, probabilmente poco nota, o comunque ingiustamente oscurata dalle brillanti novelle (ma scolasticamente fin troppo frequentate) di Ser Ciappelletto, Andreuccio da Perugia, Chichibio e la gru, Calandrino e l’elitropia, Frate Cipolla, ecc, che ci apre squarci sorprendenti sulla contemporaneità, traiettorie di riflessioni, crocevia di conoscenza, come solo la grande letteratura riesce a fare, e cioè quella letteratura che ci insegna a leggere il mondo: ad entrare in rapporto con la complessità del reale.
E magari ci aiuta anche ad immaginare uno scenario futuro.
È una pagina della cosiddetta Cornice, in apertura della IX giornata, quando i dieci novellatori, guidati da Emilia, si avviano verso un vicino boschetto.
La curiosità del lettore, di solito, è magnetizzata dalla forza esilarante, inventiva, e talvolta provocatoria delle novelle, e rischia di trascurare la situazione della Cornice del Decameron, ossia i momenti in cui le «sette nobili fanciulle e i tre giovani uomini», dopo aver deciso nella chiesa di Santa Maria Novella a Firenze nell’imperversare della sconvolgente peste del 1348, su consiglio di Pampinea, di appartarsi in un casolare fuori città, un «palagio con bello e gran cortile nel mezzo» (un vero e proprio locus amoenus di perfetta vita serena), si concedono, fra una giornata e l’altra del «novellare», momenti di svago e intrattenimento, danze e balli, passeggiate e ascolto del «divino officio» della messa in una «chiesetta lor vicina».
Ebbene, in apertura della IX giornata, la felice «brigata» s’imbatte in una sorprendente situazione: in un vicino boschetto dove i giovani stanno passeggiando, poco dopo l’alba, ecco che si mettono a giocare con animaletti selvatici, che si avvicinano a loro senza paura e intrattengono una serie di scherzose schermaglie, poiché la pestilenza ha fatto scomparire i cacciatori e gli animali hanno recuperato il loro habitat naturale.
Questo singolare episodio descritto da Boccaccio (che mostra così di saper adattare con abilità i meccanismi del simbolismo medioevale alla sua moderna narrativa e alla nuova concezione del mondo che sta disegnando) diventa uno stimolante snodo di riflessione, su quella che un grande filosofo tedesco, studioso del Decameron, come Kurt Flasch, ha definito col termine di «poesia dopo la peste», ad indicare cioè la nuova mentalità, le nuove relazioni sociali, i nuovi modi di vita, la nuova visione del mondo che si matura dopo la drammatica esperienza dell’epidemia, dove, fra le altre cose, gli animali si spingono nei luoghi naturali che erano stati occupati dagli uomini.
È un episodio del Decameron che mi è tornato in mente questa mattina, aprendo la finestra, quando ho fatto una scoperta sensazionale.
Ho buttato gli occhi sulla carrozzeria di una macchina, parcheggiata sotto il mio balcone, lì, immobile da due settimane, perché il suo proprietario, evidentemente, blindato in casa, non aveva più occasione né bisogno di utilizzarla, e sopra il tettuccio, placidamente, un uccello aveva fatto un nido. Un bel nido, rotondo, elegante.
Ora, non so come questo fenomeno sia potuto accadere (vi assicuro che è vero), ma la mia mente è tornata immediatamente allo spunto che Boccaccio, con la sua garbata ma rivoluzionaria forza d’urto, quasi settecento anni fa, ci ha consegnato: l’idea che gli eventi epocali ci spingono, pur nella tragedia, a rivedere nuove forme di convivenza civile, a ridisegnare una immagine del mondo, a ripensare al nostro modo di esistere. Ad esempio, a recuperare il rapporto con la natura, la lentezza, il silenzio, la relazione umana, il novellare, la pausa, il piacere della lettura (che così importante è nel suo «libro, cognominato prencipe Galeotto», per il suo invincibile potere di intrattenimento e nella sua capacità di rassicurare, confortare, porci delle domande).
Non si tratta di esprimere giudizi.
Ma di osservare quello che la natura ci sta suggerendo, permettendo ad un uccello di fare un nido sopra il tetto di una macchina.
Ancora una volta Boccaccio è un maestro prezioso: come lui ci presenta un’opera aperta, viva, pulsante, plastica, disponibile alle interpretazioni e alla personale responsabilità del lettore; come lui non esprime una morale ma esamina, registra, descrive, si diletta a raccontare, si diverte a stuzzicare, per lasciare al lettore un pregiato lascito di idee; come lui rappresenta una mutata concezione del fare poesia e dello stare al mondo, senza assumere posizioni moralistiche, ma presentando la complessità del reale; allo stesso modo noi, seguendo il suo magistero, siamo invitati a trarre dall’esperienza di questa pandemia un’occasione di nuova convivenza, di solidarietà, di un ritmo che stavamo rischiando di perdere. Ad interrogarci se forse prima non serpeggiava nei nostri rapporti un malessere diffuso, che cercavamo di esorcizzare con la frenesia e il rumore, senza accorgerci della segreta bellezza racchiusa in un nido.